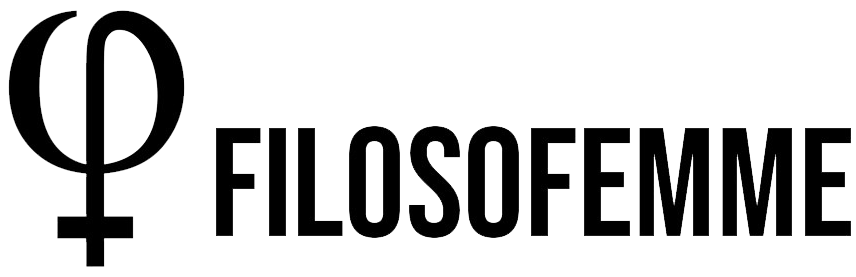Che il soggetto sia sempre agito e parlato entro e da un tessuto culturale che ne determina un posizionamento specifico secondo rapporti di potere e dominio è sicuramente uno dei lasciti fondamentali del post-strutturalismo.
È evidente tanto guardando al discorso come produzione linguistica che crea la realtà, quanto nella relazione inestricabile che il linguaggio instaura con il potere.
È Foucault, attraverso la sua ricostruzione del sapere occidentale, a mostrare che la violenza non si manifesta sempre e solo nella sua forma più aggressiva e repressiva a cui tende l’immaginario comune, ma che vi è esercizio di potere anche nelle pratiche di soggezione e assoggettamento che la stessa produzione di conoscenza può determinare.
È il caso dei manicomi in cui viene internato chi è etichettato più o meno comodamente “folle” nell’Europa del XVIII secolo, ma anche delle prigioni, delle scuole, degli ospedali.
Per il filosofo francese resta aperta la possibilità della presa di coscienza del proprio posizionamento, e quindi di un margine di resistenza alle pratiche di assoggettamento che creano il soggetto stesso.
Ma, posto che nasciamo in condizioni che non dipendono da noi, possiamo dire che questo spazio per realizzare quell’auspicabile inversione di rotta sia lo stesso per chiunque?
Naturalmente no, e a prendere sul serio la domanda, aprendo una frattura apparentemente insanabile, è Gayatri Spivak, filosofa postcoloniale il cui pensiero si forma in particolare all’interno del collettivo dei Subaltern Studies, una delle più importanti scuole di studi culturali del Sud-Est asiatico.
È un luogo in cui dare voce, nella ricostruzione storiografica dell’Indiana, alle soggettività rimaste schiacciate tanto dall’imperialismo quanto dal nazionalismo interno: chi è subalterno.
Quella «violenza epistemica (1)», che Foucault non aveva potuto vedere per il suo sguardo ancora troppo eurocentrico e che si esercita sulla precaria soggettività dell’Altrə, sulla soggettività coloniale le cui tracce vengono cancellate sistematicamente dalla storia, porta Spivak a porre la domanda in termini radicalmente diversi:
«dall’altra parte della divisione internazionale del lavoro dal capitale socializzato, dentro e fuori il circuito della violenza epistemica della legge e dell’educazione imperialista sovrapposto a un testo economico antecedente, può il subalterno parlare?» (2).
La soggettività coloniale è quindi creata sulla base dell’appropriazione e della reiscrizione del Terzo Mondo come Altro, funzionale alla costruzione di un’identità coesa dell’Occidente.
È un’arbitrarietà che però si complica ulteriormente nel caso in cui intervenga anche dalla differenza sessuale: è la donna subalterna che subisce doppiamente il silenziamento e la marginalizzazione, schiacciata tanto dalla divisione internazionale del lavoro dell’imperialismo, quanto dal patriarcato locale e nazionale. Questo scomparire della donna «non in un primigenio nulla, ma in un violento spostamento che è la figurazione spiazzata della “donna del Terzo Mondo” catturata tra la tradizione e la modernizzazione (3)» si misura in primis nei silenzi e nelle assenze dei testi stessi.
Spivak analizza in particolare la codificazione da parte dei britannici del codice legislativo indiano e l’abolizione del rituale Hindu del sati, che prevedeva il sacrificio della vedova sulla pira funeraria del marito defunto.
La voce della donna è completamente assente perché non si pongono le condizioni per cui lei possa parlare ed essere ascoltata: da un lato l’abolizione della legge da parte degli inglesi richiama un certo tipo di retorica riassumibile nell’espressione «uomini bianchi salvano donne scure da uomini scuri (4)», dall’altro l’argomento nativista indiano rivendica l’argomento nostalgico-tradizionalista per cui «le donne volevano effettivamente morire (5)».
Sono due frasi che infatti si legittimano a vicenda nella retorica della libertà di scelta la cui garanzia per la donna è in apparenza la finalità di entrambe, ma che viene paradossalmente collocata nel suo silenzio, nella sua impossibilità di entrare nel dialogo e far sentire la propria voce.
Quello che si deduce è drammaticamente chiaro: la donna subalterna non può parlare.
La sua voce resta inascoltata in quei silenzi violenti che la posizionano lungo linee di oppressione e di esclusione in una posizione assolutamente marginale.
La sfida sarà trovare una cura a questa afonia, uno sforzo tale da poter permettere a quella soggettività, il punto cieco della narrazione storica, di esprimersi, anche se fosse solo con un debole sussurro, che deve comunque essere imperativamente ascoltato.
Riferimenti Bibliografici:
- Spivak, G. C. (1988) Can the Subaltern Speak?, in Nelson, C., Grossberg, L. (Eds.). Marxism and the Interpretation of Culture, Basingstoke: Macmillan Education, p. 76. Traduzione mia.
- Ivi, p. 78.
- Ivi, p. 102.
- Ivi, p. 92.
- Ivi, p. 93.
-
20 marzo: la giornata dedicata alla felicità
20 Marzo 2019 -
Malattie croniche: una disabilità nascosta
3 Dicembre 2019 -
Principesse Disney, donne di ieri e di oggi
2 Settembre 2020
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy