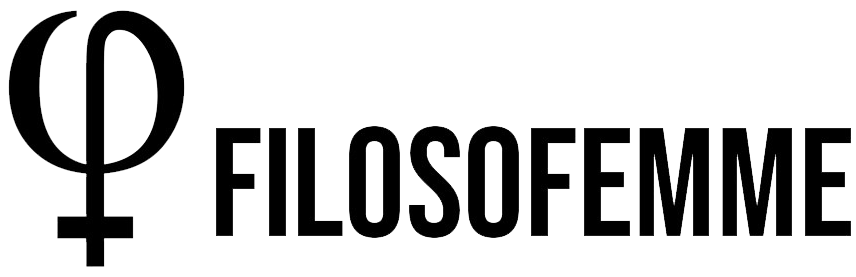Genere e Giappone. Femminismi e queerness negli anime e nei manga
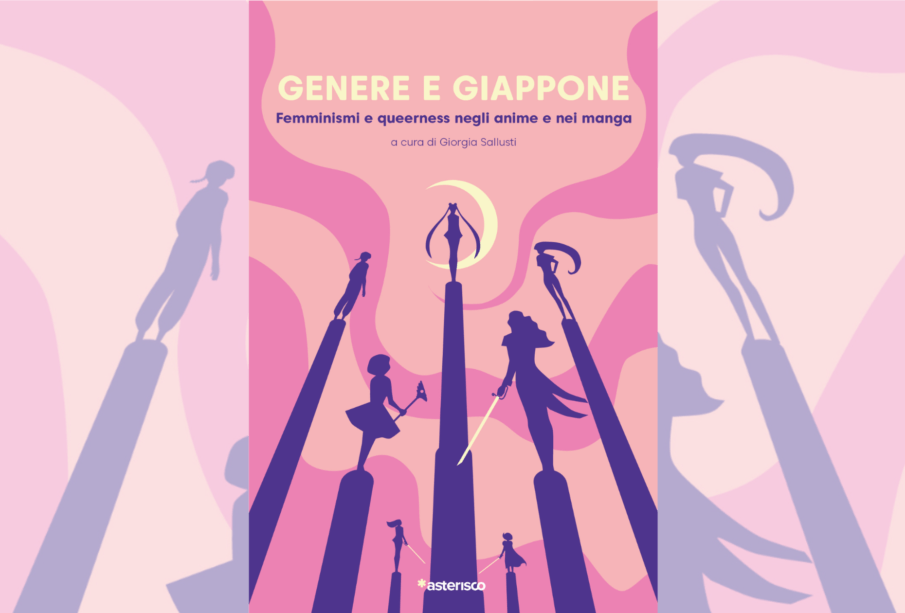
Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, esistevano dei dispositivi per ascoltare la musica: i CD.
A casa mia ne mettevamo in loop uno con le canzoni dei cartoni animati giapponesi, di cui mia sorella maggiore, classe 1984, era grande fan. E io, che non sapevo ancora scrivere, cantavo le sigle di Occhi di Gatto, Candy Candy, L’incantevole Creamy, Piccoli problemi di cuore e Papà gamba lunga.
Qualche anno dopo, ero io stessa grande fruitrice dei cartoni animati giapponesi (la parola “anime” in Italia non si usava ancora nel 2000) e, in particolare, il pomeriggio aspettavo con ansia il nuovo episodio di Rossana su Italia 1. Quando da adulta ho letto il manga da cui l’anime era tratto, Il giocattolo dei bambini (1), ho realizzato quanto i personaggi femminili usciti dalla penna di Miho Obana avessero contribuito a formare il mio carattere e la mia visione del mondo (insieme ovviamente a tutta un’altra serie di fattori: famiglia, scuola, amici, ecc.).
Non solo mi piaceva Rossana, ma aspiravo ad essere come lei: una ragazzina multitasking molto energica ed empatica che affronta i primi turbamenti amorosi adolescenziali ma, complice anche una madre forte e indipendente, non si lascia mai sopraffare ma “prova e riprova finchè ce la fa” (2). In generale, questi cartoni sono stati per me, e per moltissimə bambinə, prodotti culturali fondamentali per assimilare valori importantissimi; un contraltare necessario a tante pubblicità sessiste che intervallavano (e talvolta intervallano ancora oggi) un programma e l’altro, promuovendo i giocattoli perfetti “per le donnine di casa” (3).
Genere e Giappone. Femminismi e queerness negli anime e nei manga (4) è un ricchissimo volume che dà voce a questo pensiero con un’accuratezza e una competenza veramente encomiabile.
Ogni saggio di cui è composto racconta il sessismo della cultura giapponese attraverso il riferimento a manga di grande successo: da Sailor Moon (5) a Pollon (6), per poi passare a volumi forse meno conosciuti al pubblico italiano come quelli di Moto Hagio e Keiko Takemiya (7).
Leggendo Genere e Giappone sono rimasta impressionata dal constatare che, sotto la patina di allegri cartoni per bambinə, molti anime celassero un sessismo a cui non avevo mai fatto caso da piccola. Ad esempio, nelle pagine dedicate a Pollon, l’autrice esplora vari episodi in cui, neanche troppo velatamente, vengono raccontati in maniera grottesca e ridicola temi delicati come la violenza sulle donne, la sessualizzazione della protagonista minorenne e la mascolinità tossica degli dèi.
Questa leggerezza fa riflettere sulla mancanza di consapevolezza riguardo l’impatto che tali contenuti possono avere su spettatorə e lettorə. Il fenomeno, tuttavia, non è sorprendente e infatti, anche per autorə che hanno proposto una narrazione più innovativa, è difficile allontanarsi del tutto dai tradizionali stereotipi.
Si prenda Takeuchi Naoko. I modelli femminili della sua celebre saga Sailor Moon sono piuttosto all’avanguardia per gli anni ‘90: le protagoniste sono un gruppo di ragazze combattenti che, diversamente da altre donne come Lady Oscar, non nascondono la loro femminilità o hanno tranquillamente comportamenti fluidi (si veda Sailor Uranus).
Tuttavia, nonostante questo, Sailor Moon presenta anche stereotipi consolidati, quali «la prevalenza dell’amore romantico, l’idealizzazione esasperata di matrimonio e maternità, la bellezza come attributo puramente esteriore e infine, la convinzione che ogni ragazza sia a modo suo una piccola principessa.» (8).
Insomma, cambiare le regole del gioco è dura quando la partita è iniziata da tanto tempo.
Proprio pensando a Takeuchi Naoko, vorrei evidenziare un altro aspetto che mi ha colpito molto del saggio: la riflessione sulla situazione culturale in Giappone sviluppata attraverso le testimonianze delle mangaka donne. Il problema del genere, infatti, emerge nella rappresentazione delle donne nei manga proprio perché la disuguaglianza è presente a livello strutturale: le donne mangaka non ricevono pari trattamento dei loro colleghi, a livello di paga, di considerazione e di libertà di scrittura.
Infatti, per molto tempo, c’è stata molta riluttanza nel far scrivere shōnen (un genere manga indirizzato ad un pubblico maschile) a una donna o nel consentirle di parlare di determinate tematiche in uno shōjo (manga indirizzato ad un pubblico femminile). Fortunatamente, anche grazie allo straordinario lavoro di autrici come il Gruppo dell’Anno 24 (9), il panorama letterario oggi è molto più vario.
Dopotutto, per chi ama leggere, uno dei problemi degli stereotipi di genere è proprio il fatto che appiattisca personaggi e narrazioni, trasformando ogni racconto in una fiera del macho o in un melodramma strappalacrime noioso e, a ben guardare, completamente irrealistico.
Grazie Asterisco Edizioni!
BIBLIOGRAFIA
- M. Obana, Il giocattolo dei bambini, Dynit, Granarolo dell’Emilia 2002-03.
- Un riferimento al testo della sigla, cantata da Cristina d’Avena e Giorgio Vanni.
- https://www.youtube.com/watch?v=WwxE0j3cHRk.
- Genere e Giappone. Femminismi e queerness negli anime e nei manga, a cura di Giorgia Sallusti, Asterisco Edizioni, Sesto San Giovanni 2023.
- Ivi, pp.13-29.
- Ivi, pp. 85-102.
- Quest’affermazione si basa sulla mia personale esperienza: nessun amico a cui ho parlato di opere come Il poema del vento e degli alberi o Il cuore di Thomas conosceva le loro autrici. Sono lieta di essere smentita e di trovare nuovə compagnə con cui condividere la passione dei boy’s love!
- Ivi, p.20.
- Ivi, pp.163-177.
-
Ben venga il piacere
4 Novembre 2022 -
Leopardi era ottimista?
7 Luglio 2021 -
Donne e gatti: un legame fatto di stereotipi
16 Settembre 2019
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy