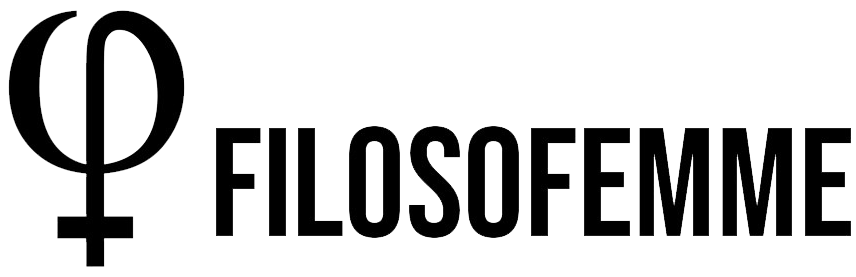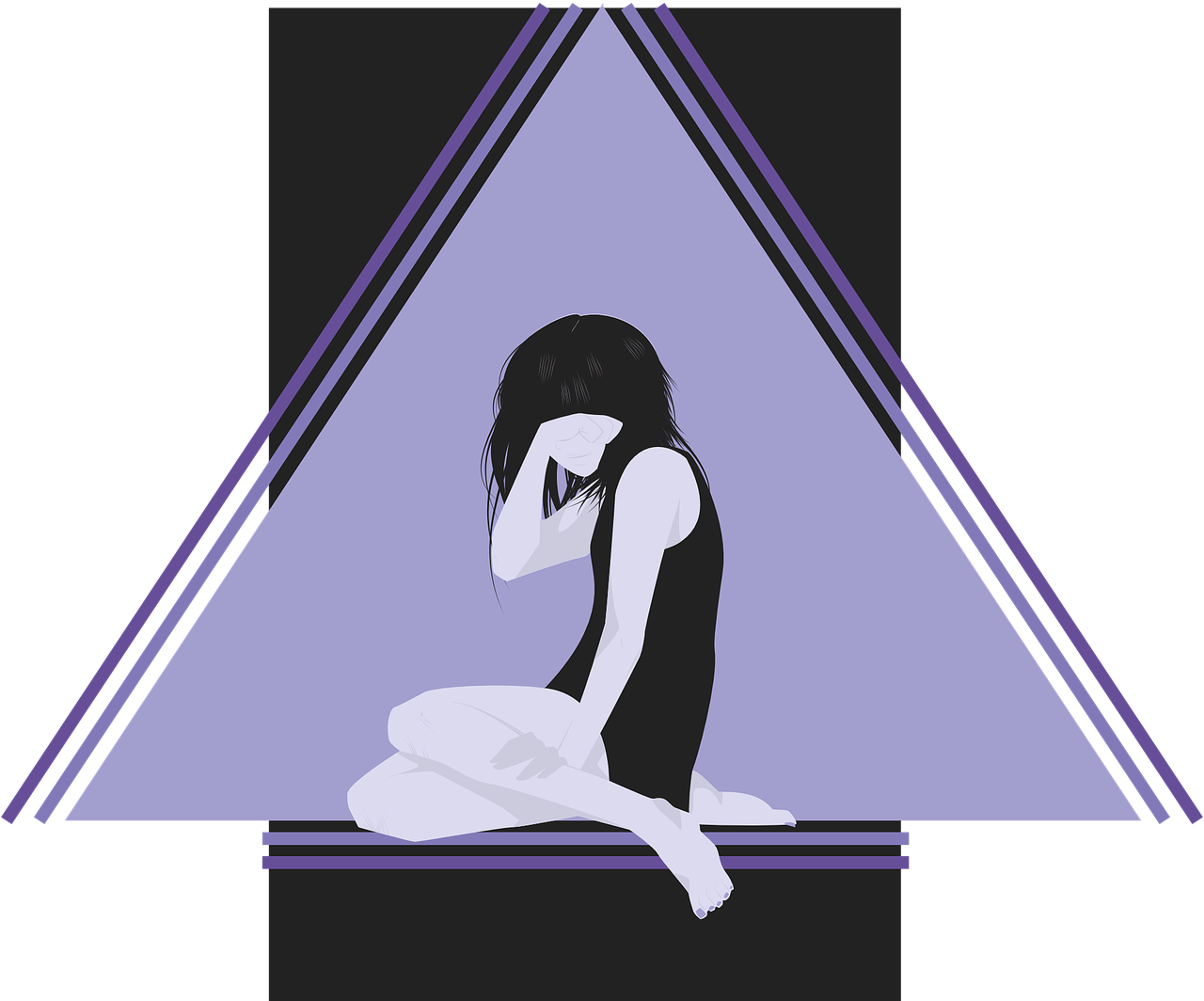La moda passa, gli anni Ottanta restano… anzi ritornano.
Sono sempre più frequenti le produzioni ispirate a quel decennio, caratterizzato da vestiti sgargianti e musica elettronica. Dal nerdissimo Ready Player One di Steven Spielberg, alle tutine colorate e ai capelli cotonati di GLOW, fino a produzioni italiane come Bang Bang Baby, serie del 2022 ambientata nella Milano di quegli anni. E non solo il cinema e la tv, anche la musica sembra sospesa nel passato. Il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS, sarà pubblicato questo 16 maggio (anche) in formato musicassetta, come fossimo nell’era del walkman invece che in quella di Spotify.
Dagli anni Ottanta non è trascorso neanche mezzo secolo eppure si sono già cristallizzati, diventando uno Zeitgeist che ha sedotto anche la Generazione Z. Ma qual è l’origine di tutta questa nostalgia?
Da avida fruitrice di ciò che è ispirato a quel periodo, non ho potuto fare a meno di pormi questa domanda. In mio soccorso è giunto Mark Fisher, filosofo e critico musicale britannico, che per anni ha cercato una risposta alla stasi vissuta dal panorama musicale del XXIsecolo.
Secondo Fisher:
«Mentre la cultura sperimentale del ventesimo secolo era preda di un delirio ricombinatorio che dava l’impressione che la novità fosse disponibile all’infinito, il ventunesimo secolo è oppresso da un soffocante senso di finitezza e sfinimento. Non si ha affatto l’impressione di trovarsi nel futuro. O in alternativa, non si ha l’impressione che il ventunesimo secolo sia già cominciato. Siamo ancora intrappolati nel ventesimo secolo.» (1)
Per spiegare l’incapacità di scrollarci di dosso il secolo passato, Fisher parte dalla riflessione sviluppata da Jacques Derrida in Spettri di Marx (2).
Nel saggio, Derrida trae spunto da un’affermazione di Marx, che nel Manifesto parlava del comunismo come di uno spettro che si aggirava in Europa prima della rivoluzione proletaria, erodendo di fatto il sistema economico con la sua sola presenza-assenza.
Da questa visione storico-politica, Derrida sviluppa il concetto di hauntologia, erede della sua metafisica della differenza (anzi, della différance): l’obiettivo è ripensare l’ontologia non più tramite il concetto di presenza, ma attraverso quello di fantasma o spettro che infesta (to haunt in inglese) il presente e lo condiziona, anche se di fatto non esiste. Per semplificarla in chiave un po’ pop, è come il famoso racconto di Dickens in cui lo Spirito del Natale futuro fa visita a Scrooge e lo spinge a cambiare vita. Si tratta di qualcosa che non è ancora avvenuto ma che, in virtù della sua sola possibilità di divenire, ha influenza sul presente.
Molti anni dopo Dickens e qualche decennio dopo Derrida, precisamente nel 2014, Fisher parlerà di hauntologisti, riferendosi ai musicisti del XXIsecolo legati agli anni Ottanta e chiedendosi perché il suo panorama culturale, quello inglese, fosse intrappolato in quelle sonorità, incapace di andare avanti.
Le cause da lui rintracciate sono essenzialmente due, intimamente connesse allo sviluppo del capitalismo liberale.
La prima è il consumismo: la sovrastimolazione causata dall’esposizione costante a nuovi stimoli commerciali spinge tutti noi a cercare conforto in qualcosa di passato, la cui stabilità ci tranquillizza e ci mette al riparo dai continui rinnovamenti a cui fatichiamo a stare dietro. La seconda causa è la necessità di lavorare.
Secondo Fisher, i provvedimenti del governo Thatcher e il ridimensionamento del welfare pubblico, hanno obbligato gli artisti ad abbandonare ogni forma di sperimentazione, orientando la loro produzione verso sonorità già sentite, che sarebbero state ben accolte dal pubblico e avrebbero garantito la sussistenza economica.
Lungi dall’essere un semplice rimescolamento di qualcosa già visto, la musica elettronica per Fisher si fa carico di un messaggio ulteriore, che rivela il profondo sconforto per l’epoca presente. Gli artisti hauntologisti non hanno nostalgia del passato, ma delle promesse che sembrava portare con sé, quel «non ancora dei vari futuri che il modernismo popolare ci ha preparato ad attendere e che non si è mai materializzato» (3). Non è il semplice fascino del passato, di cui comunque Fisher stesso riconosce i limiti, ma il desiderio di veder realizzato quel futuro che la socialdemocrazia aveva promesso e che adesso appare un fantasma la cui assenza getta nello sconforto chi nel presente vive la sua mancanza.
Fisher è morto suicida nel 2017 e tra guerre in atto, megalomani con la cravatta rossa e governi sempre più conservatori, forse siamo diventat* ancora più nostalgic*.
BIBLIOGRAFIA
(1) M. Fisher, Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti, Vincenzo Perna, Minimum Fax, Roma, 2019, p. 16.
(2) J. Derrida, Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996.(3) M. Fisher, Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti, op. cit., p. 38.
(3) M. Fisher, Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti, op. cit., p. 38.
Margherita Porete: la mistica dimenticata
13 Aprile 2025Null’altro che un lampo. Vita di Simone de Beauvoir
10 Aprile 2025Femminismo bastardo
3 Aprile 2025
-
La depressione post-coito
29 Maggio 2019 -
Il mito della bellezza: che cos’è e come liberarcene
10 Ottobre 2022 -
Lavorare meno. Se otto ore vi sembran poche
28 Marzo 2025
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy