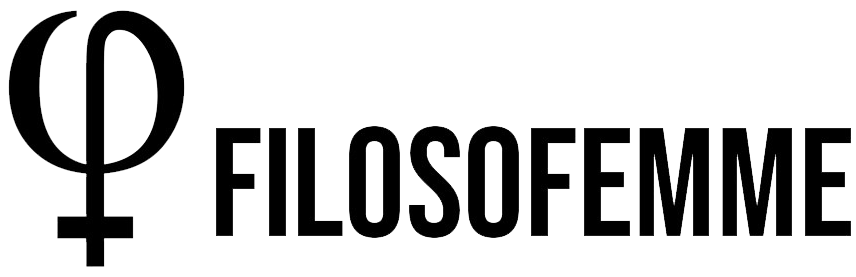Influenze e binarismo del canone di bellezza
Proviamo a chiederci (in modo particolare, se donne cis e trans) quanto il nostro aspetto esteriore contribuisce sull’andamento delle nostre vite; quanto la nostra forma fisica e il nostro peso influenzano la visione che le altre persone hanno di noi; chiediamoci quante volte al giorno veniamo espostǝ alla visione di contenuti che ci mostrano fisici “perfetti”, e come questi ci portano a maturare insicurezze e disagi rispetto a noi stessǝ.
Siamo costantemente sovraccarichǝ di influenze di questo tipo, le quali ci portano ad accostare alla nostra immagine – che sia riflessa allo specchio o impressa in una fotografia – quella misura, quel canone, quel modello che si paragona a noi e a cui desideriamo aderire ma non riusciamo. Un desiderio falso, indotto, che ci spinge sempre a provare nuovi prodotti di bellezza, a tenere il conto delle calorie giornaliere e che fa leva sulla nostra insicurezza alimentata costantemente dall’intera beauty industry. Maura Gancitano in Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza, ci invita a paragonare l’idea di bellezza alla quale siamo chiamatǝ a raggiungere, con la religione:
«che promette la salvezza e fa leva sul nostro senso di insoddisfazione, di impotenza, di inadeguatezza e sulla sindrome dell’impostore. […] Il mercato è qui per questo, per salvarci, e in effetti è pieno di riti di purificazione e redenzione: ci perdona le nostre mancanze e ci offre ciò che ci può aiutare a redimerci.» (1)
I criteri del canone della bellezza, tuttavia, colpiscono maggiormente le donne per le quali la bellezza viene associata e richiesta come valore sociale.
Esse vengono sempre più viste come degli accessori e, in quanto tali, decorativi. Perciò alle donne è possibile indossare gonne corte, vestitini a balze, e possono – ma in sostanza devono – anche colorare le unghie con lo smalto e tenere i capelli lunghi. Le donne inoltre si depilano. Tutte le rappresentazioni di donne che vediamo – ma anche quelle che conosciamo – non hanno peli (o, meglio, li hanno ma li tolgono spendendo soldi, energia e tempo). È chiaro, dunque, come il mito poggi sostanzialmente sul binarismo di genere, colpendo – ovviamente – anche quello maschile. A partire dal diciannovesimo secolo gli uomini hanno attraversato la cosiddetta «grande rinuncia maschile» (2): essi hanno rinunciato ai colori, agli ornamenti, agli accessori (pensiamo ad esempio alle iconografie di re e imperatori prenovecenteschi), diventando sempre più sobri e semplici.
Al corpo maschile non è richiesta bellezza ma unità, forza, prestazione e prontezza:
«Nel rinunciare ai colori più sgargianti e alla varietà ornamentale, gli uomini possono così metter subito in evidenza, letteralmente in un batter d’occhio, che non ne hanno bisogno, essendo presi da quelle occupazioni maschili che sono, appunto per definizione, assai ben più importanti che le pratiche ornamentali, mentre le donne, che hanno costantemente bisogno di mettersi in evidenza e adornarsi con questo e quel nuovo dettaglio per essere attraenti, continuano a portarsi addosso tutto il peso di colori, merletti e accessori.» (3)
Essere se stessǝ non significa dunque poter esprimersi in uno spazio libero, ma uno «spazio normativo» (4) costituito da regole da seguire. Tali norme dimenticano l’individualità e invitano al raggiungimento di standard predefiniti, i quali divengono gli unici socialmente accettabili: un corpo e un viso conforme avranno sempre più valore che un corpo e un viso non conforme.
Quando e come nasce il mito della bellezza?
La nascita del mito della bellezza si può ricondurre a cavallo tra la prima e la seconda Rivoluzione Industriale, ossia il momento nella storia in cui nasce la società di massa. In questo contesto il ceto medio borghese acquisisce più importanza e inizia a rappresentare i propri valori attraverso una serie di mezzi e strumenti come il gusto estetico, i valori morali, l’abbigliamento, i canoni architettonici. Iniziano dunque a giudicare il “bello” e il “brutto” in base a un codice da loro inventato.
A metà dell’Ottocento per la prima volta iniziarono a circolare riviste e pubblicità che suggerivano l’acquisto di prodotti di bellezza attraverso la rappresentazione di quelle che erano le “misure” scelte dal canone della bellezza borghese. Cominciarono ad apparire immagini di donne “belle” e “giuste” le quali rispecchiavano l’aspetto che una persona “civile” doveva avere (5). Questi strumenti ebbero una notevole divulgazione anche grazie alla nascita della rete della grande distribuzione, attraverso la quale si finiva per esercitare quello che viene chiamato soft power, ossia un potere che crea influenza per mezzo dell’ampia diffusione di simboli, valori, immagini, idee (6). Il termine soft power è stato coniato da Joseph Nye, ossia il “potere dolce” e rappresenta l’altro lato della medaglia: l’hard power, il “potere coercitivo”. Il soft power «si serve del piacere: divertimento, gusto, coolness, indorano la pillola dell’hard power» (7).
A tal proposito nel Novecento anche il cinema si unisce agli altri strumenti già in atto e inizia a influenzare il modo delle donne di camminare, di atteggiarsi, di stare con gli uomini, di essere o di non essere.
In questo processo la bellezza femminile viene sempre più a identificarsi con un valore sociale e, perciò, ad essere oggetto di grande ambizione e desiderio. Lo scopo, tuttavia, non è solo economico ma anche politico:
«Nella società contemporanea il lavoro femminile è determinante, ma rischia di dare alle donne il potere di scegliere come gestire i propri soldi, se avere dei figli e se occuparsi della politica. Diventa quindi essenziale indirizzarne i consumi e le scelte di vita per fare in modo che, nonostante acquisiscano più diritti, le donne vivano una crescente ansia da prestazione, si sforzino di raggiungere un ideale di perfezione in tutti i campi e si sentano sempre manchevoli, inadeguate, sbagliate.» (8)
E nonostante esse abbiano stipendi più bassi rispetto agli uomini, devolvono al mercato quasi tutto ciò che guadagnano per beni di non prima necessità (9). In questo modo la cura di sé così come è intesa dal mito, diviene un obbligo culturale dalle gravi conseguenze sociali e politiche.
Come liberarsi del mito
Liberarsi dalle catene della prigione della bellezza sembra veramente difficile. Svariati studi sostengono che neanche la consapevolezza e lo studio riguardanti certe dinamiche sociali sono in grado di emanciparci da certe vedute. L’alfabetizzazione mediatica – ossia la consapevolezza del potere che certe immagini suscitano – non mitiga l’effetto negativo prodotto dalle immagini stesse e, perciò, decostruire un mito che perdura da secoli richiede un processo lungo e faticoso. Al contrario, l’effetto che un’immagine pubblicitaria può suscitare è istintivo e non lo possiamo controllare (10). Gancitano nel suo ultimo saggio si chiede cosa occorre fare per eliminare i pensieri negativi sul proprio aspetto e ci spiega che la risposta è
«nella cura di sé, intesa come parte del percorso di fioritura personale. Si tratta di dedicare la propria attenzione alle emozioni, ai desideri, ai talenti, ai progetti, cercando di recuperare la capacità enterocettiva che il mito della bellezza riduce. […] Prendersi cura di noi significa prendersi cura di ciò che mettiamo in circolo, quindi anche dell’effetto che le nostre azioni hanno sugli altri. Significa, in altre parole, dare senso alla propria esistenza e seguire il proprio dàimon.» (11)
Con capacità enterocettiva si intende la sensibilità naturale agli stimoli interiori provenienti dal proprio corpo. Porre una grande attenzione sull’esteriorità fisica riduce fortemente questa consapevolezza enterocettiva e ciò ci impedisce non solo di apprezzare il nostro aspetto, ma anche di vivere a pieno le esperienze della vita e di seguire le proprie vocazioni (12).
Al contrario, la ricerca della bellezza ti invita a coltivare le esperienze di vita, ti fa sentire in fioritura e dà fiducia nel seguire la vocazione. «La bellezza è ciò che accade quando riusciamo a sentirci nel flusso.» (13)
(1) M. Gancitano, Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza, Einaudi, Torino, 2022, p. 14.
(2) J.C. Flügel, The Great Masculine Renunciation in The Rise of Fashion. A Reader, a cura di D.L. Purdy, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2004, pp. 104-120.
(3) C. Bottici, Manifesto anarca-femminista, tr. di A. Di Riccio, Laterza, Bari-Roma, 2022, p. 46.
(4) M. Gancitano, Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza, cit., p. 67.
(5) Ivi, pp. 8-9.
(6) Ivi, pp. 11-12.
(7) M. Pierri, Serie tv, numeri e presenze in Bossy, Anche questo è femminismo, a cura di B. Furci e A. Vescio, Tlon, Roma, 2021, p. 46.
(8) M. Gancitano, Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza, cit., p. 37.
(9) Ivi, p. 136.
(10) Ivi, pp. 158-159.
(11) Ivi, p. 164.
(12) Ivi, pp. 113-114
(13) Ivi, p. 172.
Il caso di Gisèle Pelicot: cos’è la rape culture?
24 Novembre 2024La crisi della nostra identità nelle separazioni
10 Novembre 2024“Ciao ChatGPT…”
3 Novembre 2024
-
Die Risikogesellschaft – la società del rischio
9 Marzo 2020 -
La medicina delle differenze
6 Febbraio 2023 -
Argomentare è diabolico
8 Aprile 2022
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy