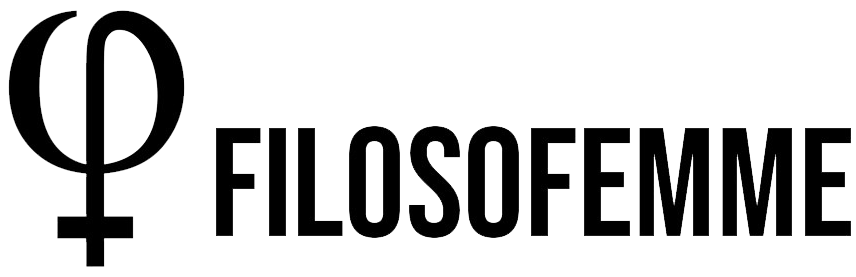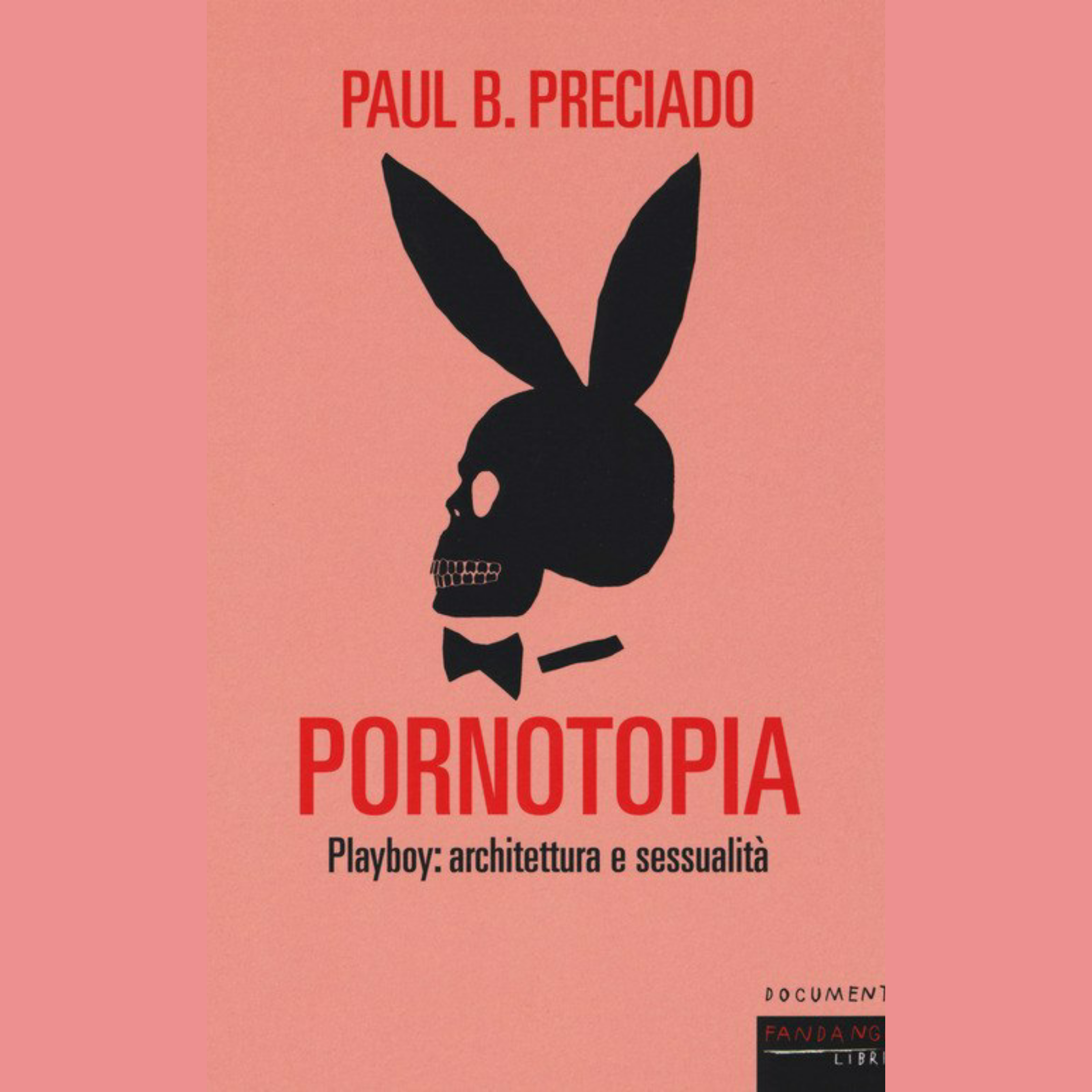⚠️ Spoiler alert: l’analisi contenuta in questo articolo contiene spoiler della serie Eric ⚠️
«La verità è che tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso».
È questa la citazione da L. Tolstoj che accompagna uno dei momenti salienti della miniserie TV Eric, ideata da Netflix e da poco disponibile sulla piattaforma streaming.
Ambientata nella New York degli anni ‘80, Eric racconta della scomparsa del piccolo Edgard Anderson, figlio dell’ideatore di un programma televisivo per bambini, rappresentando allo stesso tempo la disperazione di un padre, la tenacia di un detective e una società corrotta e stigmatizzante, sbrindellata dal capitalismo.
Edgard è un ragazzino di nove anni che vive un rapporto complicato con l’alcolista ed emotivamente violento padre, dal quale ha ereditato però il talento del disegno e dell’immaginazione.
Sarà proprio dalla fantasia del piccolo Anderson, infatti, a nascere Eric, il mostro dal quale prende il nome la serie.
Stanco delle continue liti e della conflittualità genitoriale, Edgard scappa di casa ed Eric, che prende vita dalla matita creativa del bambino, sarà l’unica ancora alla quale il padre si aggrappa nella speranza di ritrovare presto suo figlio.
Attraverso la ricerca del bambino e grazie all’ostinazione del detective a cui è affidato il caso verrà portato a galla un intreccio di corruzione, stigma e violenza che abitano il sottosuolo della metropoli americana.
Ad andare in scena a più riprese sono infatti diversi temi: la salute mentale, il complicato rapporto padre/figlio e città/cittadin3 che, attraverso un gioco di specchi, si rimandano e si intrecciano a vicenda.
Infine, ultima ma non per importanza, la marginalità.
Eric ci presenta due modelli di paternità: quello di Edgard e suo padre Vincent, ma anche quello di Vincent e suo padre, un imprenditore immobiliare. Entrambi i rapporti sono conflittuali e violenti e, forse, l’uno è direttamente il riflesso dell’altro.
Vincent mette in scena con suo figlio ciò che ha subìto a sua volta da suo padre: un rapporto violento e sminuente, volto a vincolarlo, in cui è costantemente messo alla prova, attaccato e sminuito, legato a un marchio di biasimo.
A questa relazione fanno da specchio e da eco le vicende di una New York degradata e corrotta, incapace di creare una rete di supporto, di aiuto, di benessere e sicurezza per 3 cittadin3.
A farne le spese, infatti, sono le persone più marginalizzate: Marlon, un ragazzo afrodiscendente scomparso dodici mesi prima, le cui ricerche però sono state interrotte; coloro che si ritrovano al The Lux, un club gay più volte sotto l’attenzione della buoncostume, e senzatetto che abitano nei cunicoli sotterranei della metropoli, abbandonat3 dalle istituzioni e, anzi, costrett3 allo sgombero forzato per un ricollocamento così da poter costruire nuovi palazzi e permettere nuovi investimenti.
È proprio attraverso il margine che si svincola il racconto: è nei cunicoli sotterranei dove hanno trovato dimora centinaia di senzatetto che Edgard si è rifugiato, così come è proprio grazie alle indagini sulla scomparsa di Marlon che emerge un sistema di prostituzione minorile e di clientelismo legato alla polizia e alla politica.
Il margine, allora, diventa il punto di vista dal quale la simmetria degli specchi emerge e diventa vivida: un’inversione di prospettiva che svela il rovesciamento dei rapporti subalterni padre/figlio, città/abitant3. Seguendo il figlio, infatti, il padre ritrova se stesso in quanto padre; seguendo le vicende d3 cittadin3, la città intesa come fila di relazioni e legami ritrova il suo significato e la sua speranza.
Questo legame e questo doppio gioco di rapporto in evoluzione emerge a chiari toni nell’episodio finale, quando è tra la folla dei manifestanti contro lo sgombero dei senzatetto che padre e figlio si ritrovano e, riabbracciandosi, Vincent si riscatta a sua volta dall’ombra del padre.
Allo stesso modo è attraverso le parole della madre di Marlon che la città prende coscienza della sua natura relazionale e plurale, trovando riscatto nella speranza di una nuova unione, di un nuovo legame che vada oltre le logiche capitalistiche per porre al centro le persone.
«Mio figlio aveva quattordici anni, un giorno è uscito e non è più tornato. Mio figlio era pieno di amore, pieno di speranza, di fiducia nel prossimo. Ma questo non è un mondo giusto e queste non sono regole giuste. La sua fiducia era mal riposta ma l’amore e la speranza non svaniranno. […] Mio figlio si meritava una città che l’amasse, mio figlio si meritava una città che lo proteggesse, mio figlio si meritava e sperava più di questo. La speranza che questa città, che noi potremmo fare più. Non da domani, ma da subito. Mio figlio si chiamava Marlon Rochelle. Facciamo di più. Per mio figlio, per tutti i nostri figli. Per Marlon, per favore. Di più» (1).
Il protagonista di questa serie è, quindi, il margine, che come spiega bell hooks ha il doppio significato di spazio di perdita e di resistenza.
«A volte, casa è in nessun luogo. A volte si conoscono soltanto alienazione e straniamento. Allora casa non è più un solo luogo. È tante posizioni. Casa è quello spazio che rende possibili e favorisce prospettive diverse e in continuo cambiamento, uno spazio in cui si scoprono nuovi modi di vedere la realtà, le frontiere della differenza. Sperimentare e accettare dispersione e frammentazione come fasi della costruzione di un nuovo ordine mondiale che riveli appieno dove siamo e chi possiamo diventare, e che non costringa a dimenticare.[…] Per me questo spazio di apertura radicale è il margine, il bordo, là dove la profondità è assoluta. Trovare casa in questo spazio è difficile, ma necessario.» (2)
Situarsi al margine è trovare un luogo tutto per sé, uno spazio in cui poter essere, poter (r)esistere. È stare allo stesso tempo fuori e dentro lo spazio, le relazioni, il tessuto sociale.
«Essere nel margine significa appartenere, pur essendo esterni, al corpo principale. Per noi, americani neri, abitanti di una piccola città del Kentucky, i binari della ferrovia sono stati il segno tangibile e quotidiano della nostra marginalità. Al di là di quei binari c’erano strade asfaltate, negozi in cui non potevamo entrare, ristoranti in cui non potevamo mangiare e persone che non potevamo guardare dritto in faccia. Al di là di quei binari c’era un mondo in cui potevamo lavorare come domestiche, custodi, prostitute, fintanto che eravamo in grado di servire. Ci era concesso di accedere a quel mondo, ma non di viverci. Ogni sera dovevamo fare ritorno al margine, attraversare la ferrovia per raggiungere baracche e case abbandonate al limite estremo della città. […] Vivendo in questo modo — all’estremità—, abbiamo sviluppato uno sguardo particolare sul mondo. Guardando dall’esterno verso l’interno e viceversa, abbiamo concentrato la nostra attenzione tanto sul centro quanto sul margine. Li capivamo entrambi. Questo modo di osservare ci impediva di dimenticare che l’universo è una cosa sola, un corpo unico fatto di margine e centro» (3).
Ed è proprio dal margine, inteso come frontiera, come spazio poroso, che bisogna ripartire, che ritrovare se stess3, la propria casa, la propria comunità.
1. Eric, Miniserie Netflix, ep 6, min. 30.20.
2. bell hooks, Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale, Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 66-68.
3. Ibidem.
Un materialismo queer è possibile
28 Novembre 2024Il caso di Gisèle Pelicot: cos’è la rape culture?
24 Novembre 2024Altricorpi. Scoperta del proprio corpo e dei corpi altrui
21 Novembre 2024
-
Pornotopia
5 Giugno 2020 -
Lunga vita al tortellino (?)
3 Ottobre 2019 -
Dai criminali nazisti a Cesare Battisti: le grandi fughe
23 Gennaio 2019
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy