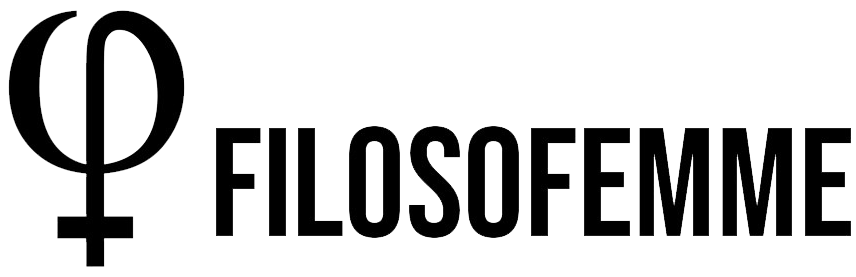Beghina itinerante, mistica e scrittrice eretica, Margherita Porete potrebbe oggi essere definita un’«Antigone solitaria» (1), e rientrerebbe certamente tra le “Morgane” di Michela Murgia. Visse in Francia tra il 1250/1260 e il 1310, anno in cui, il primo giugno, venne bruciata viva nella Place de Grève a Parigi, accusata di eresia per la scrittura del libro Specchio delle anime semplici.
Le sole notizie sulla sua vita che ci sono giunte derivano dagli atti del processo cui fu sottoposta, privandola sostanzialmente di una biografia scevra da faziosità.
Tuttavia, quel meraviglioso dialogo d’amore in cui figurano tre personaggi femminili allegorici (Amore, Ragione e Anima, quest’ultima l’autrice immaginaria del testo), dopo essere stato bruciato in pubblica piazza, continuerà a circolare esclusivamente in formato anonimo per secoli, sotto la forma di un semplice testo di devozione. La straordinaria diffusione permise a questo libro di giungere a pesatrici del calibro di Simone Weil che, nei quaderni del 1942, lo attribuisce a un anonimo «mistico francese del XIV secolo» (2).
In Italia, la scrittrice Cristina Campo e la filosofa Luisa Muraro saranno altrettanto segnate dal contatto con quest’opera e la sua potente storia.
Il processo e la condanna di Porete sono solo l’ennesima delle innumerevoli buie pagine della storia del pensiero libero medievale, che ha oscurato e gettato per secoli nell’oblio quel canto d’amore d’immensa portata spirituale e filosofica, poiché giudicato erroneus et heresum. Sarà merito della medievista Romana Guarnieri (3), con una notizia pubblicata sull’Osservatore Romano il 16 giugno 1946, riconoscere finalmente in Porete l’autrice del Miroir: contro ogni aspettativa, l’autrice risultò essere una donna, ormai dimenticata. La riscoperta della maternità del testo medievale costituisce una delle acquisizioni più rivoluzionarie nell’ambito della mistica cristiana femminile, di cui lo Specchio ci appare, ad oggi, come un’imprescindibile testimonianza.
Ma cos’è un miroir?
Si configura come un’opera esemplare del genere letterario medievale degli specula principum, testi di natura etico-didattica che, attraverso la metafora dello specchio (speculum), intendono riflettere un modello ideale da offrire a chi legge come strumento di conoscenza e perfezione morale (4). Tuttavia, Porete si appropria di questa struttura letteraria per orientarla verso un itinerario spirituale mistico, rivolto non a un destinatario reale, bensì all’anima desiderosa di ricongiungersi con Dio.
La beghina si sgancia dalla tradizione, costruendo un racconto fantastico che tocca le corde più intime di chi legge. Lo speculum, in questo contesto, non riflette solo un comportamento da perseguire, ma diviene simbolo di una radicale auto-conoscenza, che si realizza nel progressivo svuotamento dell’io come presupposto kenotico (5) di un percorso di avvicinamento a Dio.
Il dialogo tra Amore, Anima e Ragione scandisce il testo in forma pedagogica, ma ciò che ne emerge è una teologia dell’assenza e dell’impersonalità, che sovverte la mediazione clericale e scolastica, mettendo in crisi le gerarchie ecclesiastiche.
Porete, laica e isolata, sfida i suoi tempi e propone una mistica apofatica (6) che rifiuta le vie positive della conoscenza, prediligendo l’abbandono totale e l’unione immediata con il divino.
Questa prospettiva, benché radicata in alcune correnti della mistica medievale, eccede i limiti dell’ortodossia, e per questo viene condannata: il suo speculum non rispecchia la dottrina, ma la oltrepassa. La sua voce rappresenta un tentativo di conciliazione tra l’intensità devozionale delle comunità femminili e il rigore concettuale del sapere clericale, sfidando le strutture del potere teologico con un’esperienza dell’assoluto che si pone al di là di ogni autorità (7).
Quello che Porete propone nel suo testo è una descrizione utopistica di una Chiesa altra, detta Maggiore, in cui le anime semplici fanno riferimento ad Amore (che nel testo ci appare come una figura femminile), la cui lezione supera quella delle Scritture; Ragione, invece, governa la Chiesa Piccola, in cui si conservano ancora processi quali la mediazione, la penitenza o i sacramenti. Più che un progetto, si tratta di un’onirica narrazione in cui si auspica la pacifica convivenza tra le due forme di Chiese, nonché la loro reciproca influenza.
In un contesto in cui le donne risultavano completamente escluse dalle dinamiche di potere e di contributo culturale in ambito religioso, questa limitazione ha avuto l’effetto di favorire quegli infiniti e molteplici punti di fuga in cui le donne hanno trovato una loro propria modalità di esperire il fenomeno religioso (8).
Streghe, mistiche, profetesse, eretiche: ciò che queste figure hanno in comune è l’individuazione di modalità non convenzionali tramite cui accedere e vivere la propria fede, sottraendosi a quelle realtà da cui erano completamente escluse, spesso ponendosi in contrasto allo status quo della dottrina clericale.
Divenendo simbolo di coraggio e resistenza, Porete, dinanzi agli inquisitori, scelse sempre il silenzio.
In un gesto al contempo di sfida e di riaffermazione della sua dottrina, questa mistica solitaria sfidò le accuse del tribunale. Morì nel silenzio, bruciata sul rogo, ma i suoi versi, a distanza di secoli, parlano ancora per lei e ci fanno comprendere il motivo del suo gesto, coerente sino alla fine:
«Amore: Questa anima è libera, più che libera, perfettamente libera […]. Ella non risponde a nessuno, se non vuole, […] i suoi nemici non hanno risposta da lei» (9).
- M. A. Soleti, Antigoni allo specchio: la lezione d’Amore di Margherita Porete, in Storia delle donne, 4, (1), 2008, p. 83.
- S. Weil, Quaderni, volume IV, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano, 1993, p. 100.
- R. Guarnieri, Il movimento del Libero Spirito, Archivio Italiano per la Storia della Pietà IV, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1965, pp. 350-708.
- Si veda l’introduzione al testo francese del Miroir des âmes simples et anéanties di Margherita Porete, a cura di M. H. de Longchamp, Albin Michel, Paris, 1984.
- Da Kènosis, in greco “svuotamento”. Il riferimento è alla Lettera ai Filippesi 2,7 di Paolo di Tarso, da cui deriva un’interpretazione cristologica incentrata sull’evento della Crocifissione come luogo di auto-svuotamento del divino.
- Dal dizionario Treccani: apofàtico, dal greco ἀποϕατικός «negativo». Nella logica aristotelica, di giudizio che nega l’appartenenza di un predicato a un soggetto. Teologia apofantica: quella che procede alla conoscenza di Dio per via di negazioni, dicendo ciò che Dio non è.
- M. Pereira, Margherita Porete nello specchio degli studi recenti, in Mediaevistik, 1998, Vol. 11, p. 75.
- A. Valerio, Il potere delle donne nella Chiesa, Laterza, Bari, 2016, cap. V: Donne di potere.
- M. Porete, Miroir des âmes simples et anéanties a cura di M. H. de Longchamp, Albin Michel, Paris, 1984, cap. 85. Traduzione mia.
-
La teoria della riproduzione sociale
9 Maggio 2022 -
L’esistenza è una deiscenza: il sesso secondo Nancy
28 Agosto 2019 -
Steven Universe
8 Aprile 2020
Filosofemme è un progetto che nasce dal desiderio di condividere la passione per la filosofia tramite la figura delle filosofe.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Privacy PolicyCookie Policy